
Fabio Barile (courtesy Matèria, Roma), Gabriele Basilico, Silvia Bigi, Andrea Botto, Silvia Camporesi, Florence Di Benedetto, Massimiliano Gatti, Thomas Jorion e Gaia Renis sono gli artisti che mostrano il loro sguardo su un tema tanto suggestivo quanto poco esplorato: Madre Materia.
In mostra uno degli scatti della celebre serie di Beirut di Gabriele Basilico degli anni '90, dove rimane solo la memoria di quello che fu delle attività vitali della città. Andrea Botto, con la sua imagine del ponte di Calatrava di Reggio Emilia, offre un modello sublime di architettura finemente disegnata, di materia generata dall'umano ingegno in evidente contrasto con i detriti. Sempre Botto, nella fotografia dei frammenti di carte colorate che galleggiano nell'aria, immortala quelle che potrebbero essere candide e soffici nuvole: ciò che fluttua in quel cielo degno di Tiepolo è invece l'ultimo avanzo dell'esplosione di un fuoco d’artificio. Nelle immagini di Gaia Renis la materia è invece inalterata, del tutto selvaggia, persino scabra, se non minacciosa: una concrezione rocciosa, frutto di una colata lavica, natura che costruisce nuova materia. Materia costruita e poi abbandonata sono i mappamondi di Silvia Camporesi: manufatti che hanno perduto la loro funzione e con essa il loro status, non esposti e in bella vista ma accatastati alla rinfusa in un armadio, mezzi rotti e dimentichi persino della geografia. Diversamente, quasi uno scherzo del creato pare la "fontana ardente" fotografata da Silvia Camporesi sul Monte Busca. Tramandata dalla leggenda come uno sfiato vulcanico, si tratta in realtà di una sorta di geyser di gas cui la natura ha dato fuoco anticipando l'uomo con le sue ciminiere degli impianti petrolchimici. Altrettanto incontaminata è la materia indagata da Silvia Bigi, pura e umana insieme, materia che diventa emblema dell'esistenza, estratto di vita: latte e sangue, linfa dell'essere vivente, quintessenza della corporalità della donna che genera e alleva. Anche la materia rappresentata da Florence Di Benedetto è intima, anche se non corporale. Con ingrandimenti smisurati vengono mostrate le tracce lasciate dalla stecca o direttamente dal polpastrello di Medardo Rosso, immenso innovatore e precursore della scultura moderna, tracce che si fanno testimonianza dell'atto creativo, del gesto manipolatorio di Medardo che penetrala materia e le dà vita. L'astrazione la ritroviamo - seppur declinata su un registro più concettuale e meno legato all'immagine - anche nelle messe in scena di Fabio Barile. Qui, con tono oscillante tra il ludico e il metafisico, vengono fotografati allestimenti ironici ed enigmatici insieme. Totalmente senza ordine e regole è invece la realtà colta dallo sguardo di Thomas Jorion. Uno scatto che rappresenta un inno all'illogico, al casuale, dove una grossa pietra grezza è appesa ad un rubinetto montato sopra una tappezzeria rococò. Uno scherzo forse, un mistero sicuramente, ma non un'invenzione, tutto vero, eppure il trionfo dell'irrazionale, dell'ironia, del caso in perfetto stile Dada. Spogliati della loro funzione e immortalati nudi e crudi come in foto segnaletiche, sono anche i "pal ad castegn" di Massimiliano Gatti. Picchetti di legno che la tradizione contadina utilizza, piantati a terra, come rinforzi per sostenere le viti nella loro crescita, sono esempi di materia antica che ci raccontano del rapporto autentico tra uomo e natura. Invece, il sapone di Aleppo - sempre di Gatti - è materia semplice, essenza di olio e alloro; materia effimera, che da solida pian piano si scioglie, si consuma, sparisce: quasi la metafora della nostra vita sulla terra.



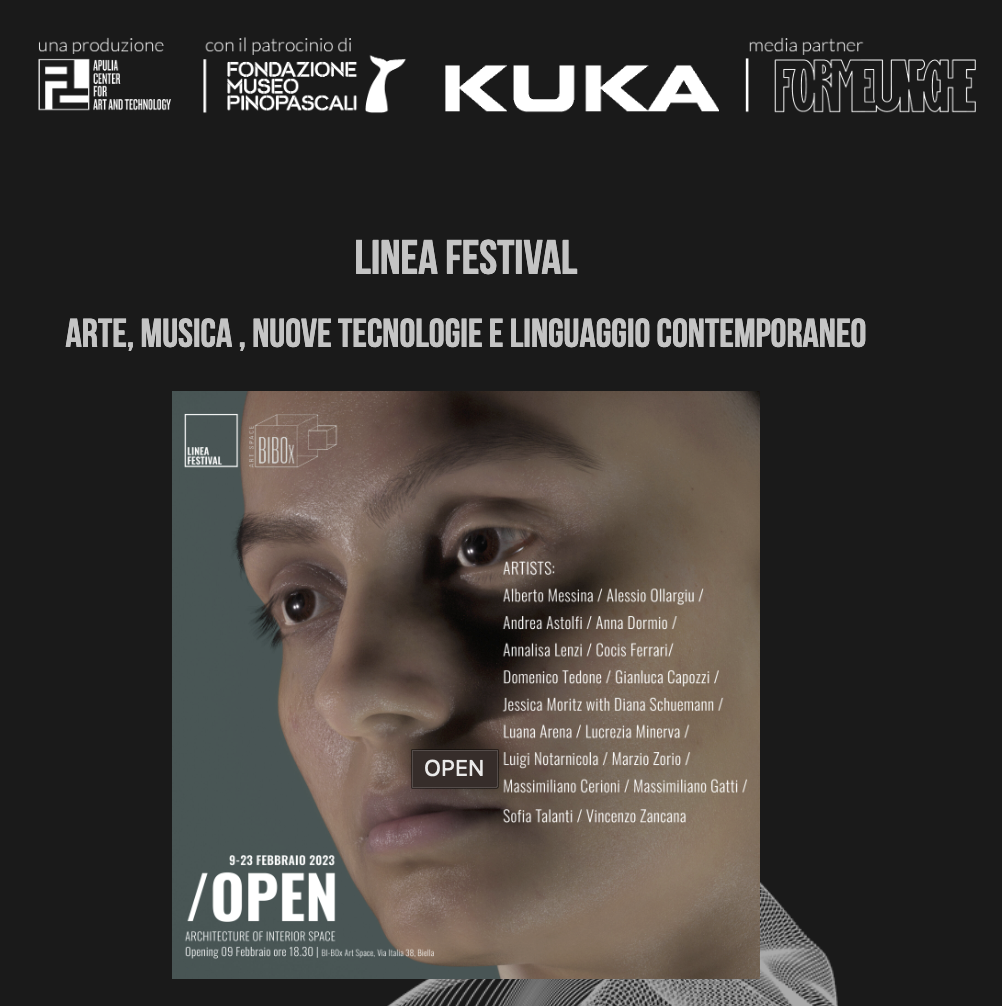








 RSS Feed
RSS Feed